Trasformare i dati dei test di usabilità in azione senza impazzire
Pubblicato: 2022-03-11La raccolta, l'ordinamento e la comprensione dei dati raccolti durante la ricerca sugli utenti e i test di usabilità sta diventando un compito sempre più comune tra i professionisti dell'esperienza utente, anzi, sta diventando un'abilità fondamentale per l'esperienza utente.
Un test di usabilità ti dirà se i tuoi utenti target possono utilizzare il tuo prodotto. Aiuta a identificare i problemi che le persone hanno con un'interfaccia utente specifica e rivela attività difficili da completare e linguaggio confuso. Tipicamente, un test di usabilità comporta una preparazione e un'analisi approfondite ed è considerato una delle tecniche di ricerca più preziose. È in grado di fornire dati sia quantitativi che qualitativi che aiuteranno a guidare il team di prodotto verso soluzioni migliori.
Tuttavia, non è una passeggiata nel parco. Nel tentativo di scoprire problemi di usabilità, i ricercatori e i designer di UX spesso devono far fronte a una marea di dati incompleti, imprecisi e confusi. Un test di usabilità regolare con cinque-dieci partecipanti può facilmente generare più di sessanta problemi. Può sembrare come "bere dalla manichetta antincendio" mentre aspetta che la temuta paralisi dell'analisi alzi la sua brutta testa.
Un rischio considerevole quando si tenta di risolvere i problemi di usabilità è andare sulla strada sbagliata cercando di trovare soluzioni che non risolvano veramente i problemi in questione. Il rischio è che ci possa essere una disconnessione tra i problemi riscontrati e le soluzioni identificate. Questi possono essere causati da una serie di fattori diversi, tra cui l'affaticamento decisionale e molti tipi di pregiudizi cognitivi.
Come trasformare i dati dei test di usabilità in soluzioni praticabili
Per superare gli ostacoli sopra menzionati, abbiamo bisogno di modi efficienti per gestire i nostri dati di test assicurandoci di scegliere le soluzioni più efficaci per i problemi riscontrati.
Iniziamo prendendo in prestito alcune idee dal processo creativo. Uno dei più potenti è il doppio diamante del British Design Council, che a sua volta utilizza il pensiero divergente-convergente. È un processo di progettazione con fasi di problemi e soluzioni chiaramente definite e integrate.
Il doppio diamante è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per costruire un framework che gestirà i problemi di usabilità e troverà il modo di risolverli.
L'adattamento del modello sopra al test di usabilità del risultato è un processo in quattro fasi:
- Raccolta dati
- Assegnazione delle priorità ai problemi
- Generazione di soluzioni
- Assegnazione delle priorità alle soluzioni
Vediamo ogni passaggio nel dettaglio, compreso come metterlo in pratica.
Nota: avremo bisogno di usare un po' di matematica di base. Non preoccuparti, non è troppo e alla fine di questo articolo troverai un foglio di calcolo che automatizza l'intero processo. Se ancora non funziona per te, c'è anche un approccio visivo in cui puoi utilizzare Post-it e lavagne.
Passaggio 1: raccolta dei dati della ricerca sull'usabilità
A partire dalle tue domande di ricerca , il primo passo è raccogliere i dati generati dal test di usabilità. Deve essere configurato per una facile generazione di idee e approfondimenti più avanti nel processo: la chiave è strutturare e organizzare chiaramente i dati per evitare disordine. Nella maggior parte dei casi è sufficiente:
- Avere un sistema di identificazione del problema (ID).
- Nota dove è successo (schermo, modulo, widget dell'interfaccia utente, flusso, ecc.)
- Conoscere l' attività in cui si stava impegnando l'utente
- Fornire una descrizione sintetica del problema
Un approccio comune per organizzare i problemi di usabilità, utilizzato da Lewis e Sauro nel libro Quantifying the User Experience , consiste nel tracciare i dati come mostrato nella tabella seguente, con problemi nelle righe e partecipanti nelle ultime colonne.
Nell'esempio sopra, un test di usabilità fittizio realizzato con tre partecipanti ha prodotto due problemi:
- La prima vissuta dal partecipante (P1)
- La seconda dagli altri partecipanti (P2 e P3)
Passaggio 2: definizione delle priorità dei problemi
Poiché le risorse sono limitate, è necessario dare priorità ai problemi di usabilità in modo da ottimizzare l'analisi. Tipicamente, ogni problema di usabilità ha un grado di gravità , influenzato da alcuni fattori come:
- Criticità dell'attività: valutata in termini di impatto sull'azienda o sull'utente se l'attività non viene eseguita.
- Frequenza del problema: quante volte si è verificato un problema con vari partecipanti.
- Impatto del problema: quanto ha influito sull'utente che tenta di eseguire l'attività.
Per stabilire la priorità, dobbiamo seguire questi passaggi:
Impostare il punteggio di criticità di ogni attività eseguita nel test. In poche parole, definisci l'importanza dell'attività per l'azienda o l'utente impostando un valore numerico. I valori possono provenire da una semplice sequenza lineare (es. 1, 2, 3, 4, ecc.) o da qualcosa di più elaborato come la sequenza di Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, ecc.), esattamente come usata in metodi agili come pianificare il poker.
- Imposta il punteggio di impatto per ogni problema assegnando un valore (come sopra) per gli elementi in questa scala:
- 5: (blocco) il problema impedisce all'utente di eseguire l'attività
- 3: (maggiore) provoca frustrazione e/o ritardo
- 2: (minore) ha un effetto minore sull'esecuzione del compito
- 1: (suggerimento) è un suggerimento del partecipante
Trova la frequenza di emissione (%) del problema dividendo il numero di occorrenze per il totale dei partecipanti. È un calcolo percentuale di base.
- Infine, calcola la gravità di ogni problema moltiplicando le tre variabili sopra.
Vediamo come funziona in un foglio di calcolo (ovviamente vogliamo automatizzarlo, giusto?). La nostra tabella aggiornata sarebbe simile a questa:
Nell'esempio sopra, abbiamo il seguente scenario:
- Tre problemi di usabilità riscontrati da tre partecipanti (p1, p2 e p3);
- L'attività "crea un post" appare due volte e gli viene assegnato un livello critico di 5 e un'attività meno critica (accesso social) ha assegnato un 3;
- Ad ogni problema è stato assegnato un valore dato il suo impatto : 5 (blocco), 3 (maggiore) e 2 (impatto minore sulle prestazioni del compito);
- La frequenza di ogni numero (es. numero 2 si è verificato due volte con tre partecipanti, quindi 2/3 = 0,67);
- Infine, la gravità risultava dalla moltiplicazione degli altri fattori (es. 3 x 5 x 0,33 = 4,95).
Per ora è tutto. Abbiamo trovato i nostri problemi di usabilità più importanti in questo ordine: 3 , 2 e 1 . In questa fase, abbiamo anche una buona prospettiva sul panorama dei problemi di usabilità, il quadro generale che aiuta il team a inquadrare il problema di alto livello e ottimizzare durante i passaggi successivi.
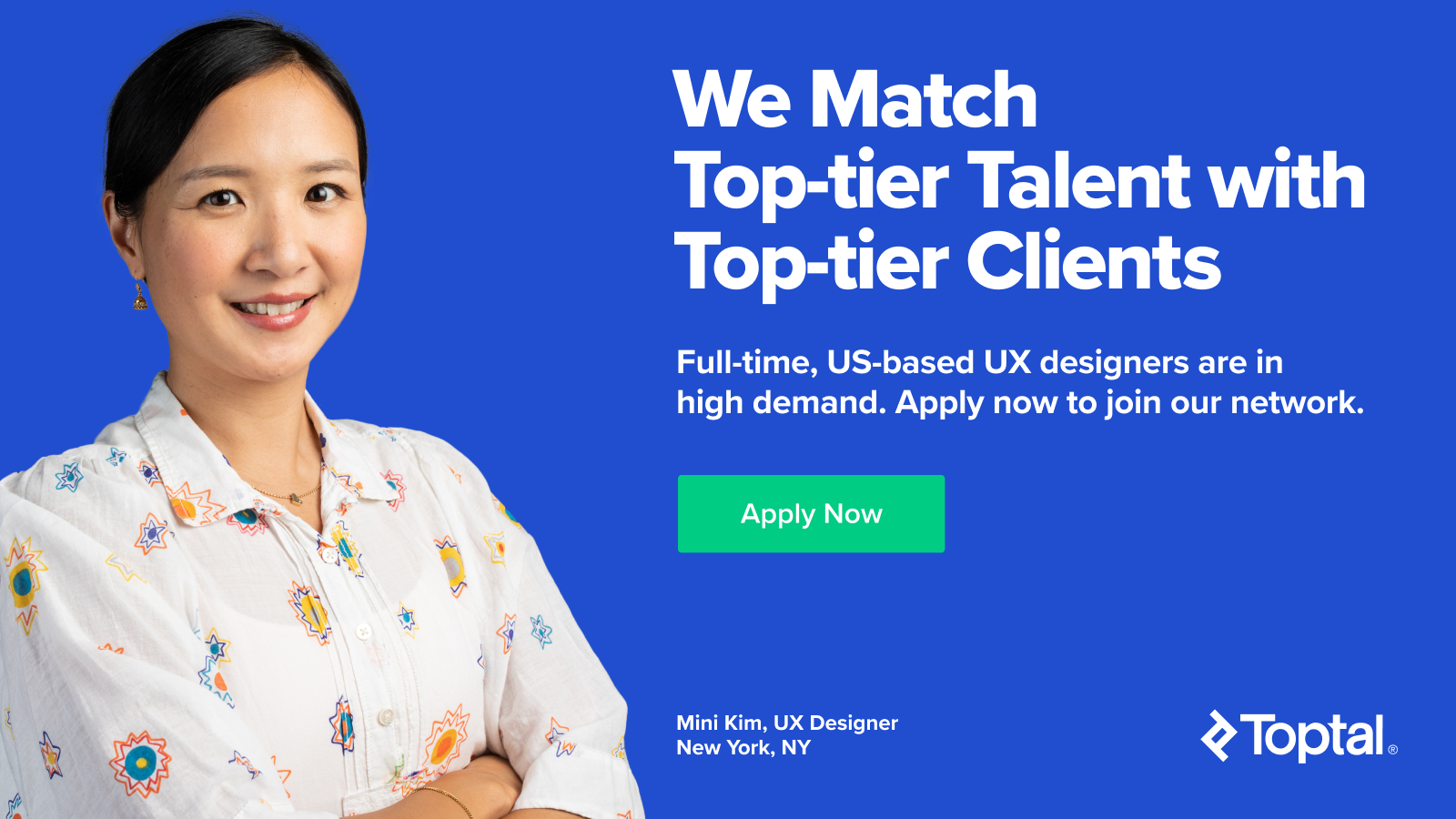
Passaggio 3: generazione di soluzioni
Tipicamente, i test di usabilità non sono completi alla conclusione senza un elenco di raccomandazioni (suggerimenti generici) e soluzioni (istruzioni specifiche). A volte la soluzione è abbastanza ovvia, come correggere il posizionamento di un componente dell'interfaccia utente. La situazione diventa più complicata per quei problemi con soluzioni non ovvie o molte possibili. Quale soluzione è migliore? Quale è più fattibile? Qual è il costo/beneficio dell'esecuzione di un esperimento per scoprirlo? Qui, il metodo tradizionale di raccomandazioni regolari non sarà sufficiente.
Per ridurre il rischio di prendere decisioni di progettazione sbagliate, abbiamo bisogno di: a) diverse soluzioni alternative tra cui scegliere eb) un processo di selezione efficace. Utilizzeremo lo stesso approccio divergente-convergente utilizzato per affrontare la raccolta dei dati e le fasi di definizione delle priorità nella fase precedente. I passaggi sono:

Per ogni problema, genera più idee di soluzione : quali sono i modi possibili per affrontare il problema? Qui abbiamo una grande opportunità di collaborazione con il resto del team (sviluppatori, designer, product manager, ecc.).
Riorganizzare le soluzioni, mantenendole specifiche, secondo necessità, unire o dividere le soluzioni per evitare ridondanze e troppa astrazione. Ancora una volta, sii specifico, in modo che sia più facile valutare le idee. Ad esempio, invece di limitarsi a "Evitare di utilizzare un menu di hamburger", è meglio indicare una soluzione specifica, ad esempio "Usa una navigazione orizzontale e un menu ad albero verticale".
Segna ulteriori problemi che la soluzione potrebbe risolvere: in pratica, un'unica soluzione valida può risolvere più problemi. Le buone soluzioni sono versatili!
Seguendo i passaggi precedenti, la tabella risultante è simile alla seguente:
In questo esempio, abbiamo l'elenco delle soluzioni di brainstorming (righe) e i problemi affrontati da ciascuna soluzione (colonne, che rappresentano i problemi riscontrati nei passaggi precedenti).
Successivamente, vediamo come evolvere questo elenco e scoprire quali soluzioni sono i migliori candidati per l'implementazione e in quale ordine.
Passaggio 4: priorità della soluzione
Analogamente alla definizione delle priorità dei problemi, è necessario assegnare la priorità alle soluzioni in base ad alcuni parametri. Nei team agili, in cui questo argomento viene trattato molto seriamente, è comune utilizzare il valore e la complessità del business , che ci consente di calcolare il ritorno sull'investimento (ROI). Prendendo in prestito da questa logica, abbiamo i seguenti passaggi:
Calcola l' efficacia di ogni soluzione .
Più grave è il problema affrontato, migliore è la soluzione. Questo potrebbe essere approssimativamente paragonato al valore aziendale nei metodi agili. Somma la gravità di tutti i problemi affrontati dalla soluzione.Effectiveness = Sum of issue severities- Affina la complessità della soluzione .
- Quali sono le risorse necessarie per sviluppare questa soluzione?
- Quanto sono standard le tecnologie coinvolte?
- Quanto sono chiari i requisiti dell'azienda/dell'utente?
In altre parole, maggiore è lo sforzo e l'incertezza, più complessa è la soluzione. Basta tradurre questo in un valore quantificabile, come la sequenza di Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, ecc.). Se stai facendo questo come una squadra, la pianificazione del poker si adatta perfettamente.
Calcola il ROI della soluzione. Questo è il rapporto costo-beneficio, calcolato dividendo l' efficacia della soluzione per la sua complessità . Maggiore è il ROI, meglio è.
ROI = Effectiveness / Complexity
Torniamo al nostro foglio di lavoro, che ora si presenta così:
Nell'esempio sopra abbiamo:
- L'elenco delle soluzioni (righe)
- I problemi (da i1 a i3) con la loro gravità (4.95, 6.7 e 10.05)
- Un indicatore di 1 ogni volta che una soluzione corrisponde (indirizza) un problema
- L'efficacia di ogni soluzione (4.95, 4.95 e 16.75)
- La complessità di ciascuna soluzione (1, 3 e 5) stimata dal team
- Il ROI di ciascuna soluzione (4.95, 1.65, 3.35)
Secondo questo esempio, dovremmo dare la priorità allo sviluppo delle soluzioni nel seguente ordine (dalla ROI più alta a quella più bassa): soluzione 1, quindi soluzione 3 e 2.
Per riassumere i passaggi: abbiamo iniziato raccogliendo dati, quindi abbiamo assegnato la priorità ai problemi in base a parametri specifici. Successivamente, abbiamo generato idee di soluzione per questi problemi e, infine, abbiamo assegnato loro la priorità.
Utilizzando un foglio di calcolo
Il metodo sopra prevede alcuni calcoli (di base) ripetuti molte volte, quindi è meglio utilizzare un foglio di calcolo.
Se vuoi seguire questa metodologia, ecco un modello (Foglio Google): https://goo.gl/RR4hEd. È scaricabile e puoi personalizzarlo liberamente in base alle tue esigenze.
Odio i fogli di calcolo! Che ne dici di qualcosa di più visivo?
Quasi tutti quelli che conosco (me compreso, ovviamente) adorano lavorare con le note adesive e le lavagne, non solo perché di solito è più veloce e divertente, ma anche perché facilita la collaborazione. Se sei un professionista agile o di design thinking, sai cosa intendo. Come possiamo applicare strumenti visivi come le note adesive per lavorare con l'approccio mostrato in questo articolo? Bene, questo probabilmente merita un intero post sul blog, ma proviamo a grattare la superficie.
Un modo per farlo è creare una matrice per i problemi (impatto x frequenza) e posizionarla accanto a un'altra per le soluzioni (efficacia x complessità). Ogni matrice è divisa in quattro quadranti, che indicano la definizione delle priorità.
Ecco i passaggi:
Creare la matrice del problema inserendo le note adesive nel quadrante corretto in base all'impatto e alla frequenza . Per semplificare questo approccio, abbiamo dovuto omettere un parametro. In questo caso, la criticità dell'attività .
Crea la matrice della soluzione organizzando le note adesive in base all'efficacia e alla complessità di ciascuna soluzione:
Brainstorm soluzioni per ogni problema, a partire dai problemi nel quadrante 1 della matrice dei problemi (quelli con gravità maggiore).
Posizionare queste soluzioni nella matrice della soluzione, a partire dal quadrante 1 (in alto a sinistra). Più grave è il problema, più efficace sarà la sua soluzione.
Regola la complessità di ciascuna soluzione spostandola sull'asse orizzontale (più è complessa, più si sposta a destra).
Ripetere i passaggi precedenti per le questioni rimanenti (quadranti 2, 3 e 4, in questo ordine).
Alla fine dell'esercizio, le soluzioni nel quadrante 1 sono quelle con il miglior ROI (più efficace e meno complesso) a significare la massima priorità. Il risultato è mostrato nell'immagine qui sotto:
Compreso il fatto che abbiamo omesso un parametro (criticità dell'attività), lo svantaggio qui è che devi fare affidamento sull'accuratezza visiva anziché sui calcoli come nel foglio di calcolo. Il lato positivo è che abbiamo un metodo che favorisce la collaborazione, che a volte è fondamentale per ottenere il consenso del team.
Promuovere la collaborazione attraverso un'analisi visiva "rapida e sporca" al probabile costo dell'accuratezza è un potenziale compromesso. Qual è l'approccio migliore? La risposta breve: quella che meglio si adatta alla tua situazione ed è meglio allineata ai tuoi obiettivi.
Conclusioni finali per l'analisi dei dati dei test di usabilità
L'uso di queste metodologie ha portato alle seguenti osservazioni da parte dei team che lo hanno utilizzato in vari progetti:
Soprattutto quando si tratta di studi più grandi, la definizione delle priorità mantiene il team concentrato su ciò che conta davvero, risparmiando tempo e risorse riducendo le sfide cognitive indesiderate come il sovraccarico di informazioni, la paralisi dell'analisi e l'affaticamento decisionale;
Il flusso di lavoro end-to-end connesso mantiene le soluzioni più allineate con i risultati dei test di usabilità (perché problemi e soluzioni sono associati), riducendo il rischio di implementare soluzioni non ottimali;
Possiamo facilmente applicare questo metodo in modo collaborativo (in parte o nel suo insieme) utilizzando strumenti online.
È importante comprendere i limiti di questo approccio. Ad esempio, durante la fase di definizione delle priorità, gli atteggiamenti e i comportamenti positivi degli utenti osservati nei test non sono inclusi. Il focus è sui problemi di usabilità. Un suggerimento è di registrare questo tipo di dati separatamente e di utilizzarli lungo il percorso per integrare e bilanciare i risultati secondo necessità.
Infine, oltre ai test di usabilità, questo approccio può essere esteso anche ad altre tecniche di ricerca UX. Applicando l'approccio del "doppio diamante" (problemi e soluzioni divergenti/convergenti), possiamo mescolare vari dati di ricerca degli utenti e utilizzare i metodi sopra in qualsiasi altro progetto. La tua immaginazione è il limite!
• • •
Ulteriori letture sul blog di Toptal Design:
- eCommerce UX: una panoramica delle migliori pratiche (con infografica)
- L'importanza del design incentrato sull'uomo nel design del prodotto
- I migliori portfolio di designer UX: casi di studio ed esempi stimolanti
- Principi euristici per interfacce mobili
- Design anticipatorio: come creare esperienze utente magiche
